PASQUE VERONESI E LA CADUTA DELLA SERENISSIMA
Storia
Di Pietro Minute
1797, la Repubblica Serenissima di Venezia, all'epoca alleata con l'Austria, viene militarmente occupata dalle truppe francesi, violando La neutralità del paese quindi de facto invadendolo. Sebbene all'inizio la Serenissima ci teneva a tenere la neutralità, ben presto le rivolte popolari e le continue vessazioni da parte dell'esercito francese, portarono a degli scontri civili ingenti.Tutto iniziò, dopo l’impresa del generale Napoleone Bonaparte, nell’invasione della Lombardia, ad occupare militarmente Bergamo, all’epoca sotto controllo di Venezia, per intraprendere azioni militari contro l’Austria.Alessandro Ottolini, podestà di Bergamo, aveva offerto 10.00 uomini per la difesa della Nazione Bergamasca.All'arrivo delle milizie francesi, Ottolini fece chiudere l'accesso al castello cittadino, ma i francesi riferirono che avevano ricevuto l'ordine di presidiare il castello e la fortezza e come già i podestà di Brescia e Verona, anche Ottolini fu obbligato ad acconsentire. I francesi comunque non tolsero i vessilli di San Marco, dato che ufficialmente anche questa città permaneva sotto il controllo veneto. Ottolini nel contempo aveva richiamato alcune compagnie militari dalla provincia, e questa sua azione venne utilizzata come pretesto per l'occupazione della città. Bergamo diveniva ufficialmente la prima città sottratta al dominio di Venezia, e Ottolini fu obbligato a abbandonarla.Il passo successivo per i francesi, doveva essere l'invasione di Brescia: in questo caso, anche se la città era già sotto il parziale controllo francese, l'operazione avrebbe dovuto essere condotta, almeno in apparenza, dai giacobini, dato che nel caso bergamasco l'azione francese era stata troppo evidente. Il 16 marzo colonne di soldati composte in parte da giacobini lombardi e in parte da soldati francesi partirono alla volta di Brescia. Il podestà, Giovanni Alvise Mocenigo, avrebbe voluto portare un attacco alla colonna nemica, ma venne fermato dal procuratore Battaia.
Due giorni dopo 200 uomini entrarono a Brescia e, con l'aiuto dei giacobini, vinsero le poche resistenze. Il primo provvedimento fu la cacciata di Battaia, che si rifugiò a Verona. Nonostante la mancanza di favore nella popolazione, i giacobini riuscirono, con l'aiuto francese, a prendere il contado.Il provveditore Battaia giunse a Verona il 22 marzo e subito fece riunire il consiglio, al quale parteciparono anche alcuni capi militari.Durante il consiglio i comandanti Maffei, Ottolini ed Emilei si batterono per convincere gli altri membri dell'importanza della riconquista dei territori perduti.Si passò subito all'opera: Miniscalchi assunse il comando delle difese lungo la linea del lago di Garda, mentre a Bevilacqua fu assegnato quello della linea tra Villafranca di Verona e il confine con Ferrara. Tra le due linee venne posizionato Maffei. Inizialmente i capi militari furono mandati a difendere i confini con un numero esiguo di soldati, però i comandi cernidi poterono offrire 6.000 uomini, inoltre si unirono numerosi volontari, in particolare dalla Valpolicella. Il 23 marzo giunse a Verona la notizia che era partita da Brescia una spedizione di 500 soldati giacobini diretti a Peschiera del Garda o Valeggio sul Mincio: gli ufficiali e le truppe si affrettarono così a prendere le posizioni. Miniscalchi si recò a Colà, sopra le colline di Lazise, Giusti a Povegliano Veronese e Bevilacqua a Cerea, mentre Maffei raggiunse Valeggio, da dove poté constatare che i nemici non erano ancora in vista, e poté quindi rischierare con più ordine le sue truppe. A lui si unirono anche 24 fanti provenienti da Brescia e 40 cavalleggeri croati arrivati da Verona. Il 27 marzo decise di inviare un corpo di esplorazione mentre, nel frattempo, a Castelnuovo del Garda si erano riuniti 1.500 volontari. Il 29 marzo i francesi si scontrarono per la prima volta con gli insorti a Villanova, vicino a Salò. La notizia dei movimenti delle truppe nel veronese arrivò sino nelle valli bergamasche, dove scoppiarono numerose rivolte contro gli occupanti.Si sollevò pressoché tutta la zona montuosa bergamasca, tanto che gli insorti, cacciati i francesi, decisero di puntare su Bergamo. Negli stessi giorni, nel bresciano, insorse la popolazione di Salò. Un secondo scontro fu vinto dai Veneti grazie all'attacco su tre lati dei montanari della Valle Sabbia: tra le truppe nemiche ci furono 66 morti e numerosi prigionieri, tra cui alcuni capi dei giacobini. Anche le popolazioni della Val Trompia, in particolare quelle dell'alta valle delle comunità di Bovegno, Collio e Pezzaze, erano insorte armate e i francesi con i loro alleati giacobini furono fermati a Carcina, alle porte della Val Trompia, dove si combatté accanitamente e con numerosi morti da ambo le parti. Nel frattempo gli insorti di Calcinato e Bedizzole cacciavano i giacobini locali, sbloccando così la strada per Salò, i Veneti raggiunsero la cittadina catturando numerosi giacobini in fuga.
Nel frattempo un attacco veronese a Desenzano non ebbe fortuna: le notizie delle fortunate insorgenze nelle valli bergamasche e bresciane, a Lonato e a Salò portarono eccitazione nei territori della Repubblica di Venezia. Lo stesso giorno, però, i francesi attaccarono gli insorti che avevano circondato Bergamo e il giorno successivo si svolsero altre due battaglie: una vinta dai francesi e una dai Veneti, che dovettero comunque ritirarsi sulle montagne e arrendersi, data la evidente superiorità francese.Maffei era deciso a marciare su Brescia ma venne fermato da Battaia poiché la Francia, secondo lui, poteva utilizzare l'azione come pretesto per dichiarare guerra alla Serenissima. Avendo Maffei, l'appoggio dei rappresentanti del governo veneto in città,(Iseppo Giovannelli e Alvise Contarini), ebbe il via libera ad avanzare, ma con l'ordine di fermarsi a 13 km da Brescia: le truppe marciarono superando il Mincio sino ad avvicinarsi alla città che, insieme agli insorti, fu bloccata su tre lati. I francesi radunarono a Milano 7.000 uomini e partirono verso Brescia. Intanto a Brescia il generale francese Landrieux minacciò Maffei di raggiungere Verona a colpi di cannone se egli non avesse sgomberato il campo, così, dopo due brevi scontri tra truppe venete e francesi l'8 e il 9 aprile, Maffei decise di ritirarsi verso Verona. Iniziarono le Pasque veronesi. Dopo una settimana di relativa calma, nella notte tra il 16 e il 17 aprile 1797 fu affisso per le vie della città un manifesto firmato da Francesco Battaia che incitava i veronesi alla rivolta contro i francesi e contro i collaborazionisti giacobini:
«Noi Francesco Battaia, per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditor Estraordinario in Terra Ferma.Un fanatico andare di alcuni briganti nemici incutè a stendere un'orda di facinorosi prezzolati in altre città e provincie dello Stato Serenissimo. Contro questi nemici del Principato noi eccitiamo i fedelissimi sudditi a prendere in massa le armi e dissiparli e distruggerli, non dubiti alcuno dell'esito felice di tale impresa, giacché possiamo assicurare i popoli che l'Armata Austriaca ha completamente battuto i Francesi nel Tirolo e Friuli, e sono in piena ritirata i pochi avanzi di quelle orde sanguinarie e irreligiose, che sotto il pretesto di far la guerra a nemici devastarono paesi e concussero le Nazioni della Repubblica. Viva San Marco! Viva la Repubblica! Viva Verona!»
La situazione degenerava di ora in ora: verso le 14:00 del 17 aprile venne arrestato un artigliere veneto mentre negli stessi istanti presso un'osteria in via Cappello scoppiò una rissa tra un francese e un croato. Il francese ebbe la peggio e andò a rifugiarsi presso la propria pattuglia. Fu allora che il popolo armato accorse in massa e, nel trambusto tra popolani e soldati, partì un colpo di fucile che mise in fuga i francesi. Poco dopo scoppiò un'altra rissa in un'osteria di piazza delle Erbe, mentre alcuni popolani furono fermati da ufficiali dell'esercito veneto prima che aggredissero le guardie ai ponti Pietra e Nuovo. I comandanti francesi diressero allora in città alcune truppe e inviarono in piazza Bra circa 600 uomini per controllare l'evolversi della situazione.Verso le 17:00, per ordine del generale Balland, venne aperto il fuoco dei cannoni di castel San Felice e castel San Pietro, da dove numerosi colpi giunsero sino in piazza dei Signori. Il primo episodio dell'insurrezione si ebbe in piazza Bra dove i 600 soldati francesi erano in sosta presso l'ospedale (palazzo Barbieri), mentre circa 500 soldati veneti si trovavano presso il Liston e sotto la Gran Guardia. Appena si udirono i primi colpi di cannone i francesi raccolsero le armi e si avviarono velocemente verso Castelvecchio, mentre i soldati veneti stettero ad assistere disorientati, poiché per mesi i loro comandanti avevano ricordato l'importanza della neutralità. Il popolo si accanì contro le truppe francesi sparse in tutta la città. Numerosi soldati furono uccisi o fatti prigionieri, mentre quelli messi in fuga andarono a nascondersi negli alloggi dei compagni, dove barricarono le entrate: i popolani, per penetrare in quelle abitazioni, arrivarono a salire sui tetti.Francesco Emilei in quei momenti era accampato vicino a Lugagnano, appresa la notizia della rivolta mosse verso Verona con i suoi soldati. Le porte urbane erano però difese dai francesi, che la mattina avevano raddoppiato i presidi. Emilei dall'esterno della città conquistò porta San Zeno e poté entrare con 2.500 volontari , 600 soldati e due cannoni. Nel tardo pomeriggio i rappresentanti del governo, pensavano ancora di poter tornare al precedente stato di neutralità, mentre Emilei, appena conquistata porta Nuova, decise di partire per Venezia per chiedere il soccorso dell'esercito veneto. I governatori, spaventati per l'evolversi della situazione, decisero di ritirarsi a Vicenza e ordinarono, prima della partenza, che le truppe non prendessero parte alla battaglia.Il 18 aprile, Giovannelli e Contarini, si sarebbero diretti a Venezia, per chiedere aiuto al Senato. Nel frattempo la popolazione continuò ad assaltare gli edifici in cui vi erano i soldati francesi, che venivano sistematicamente uccisi, mentre «non si sentiva altro che un continuo gridare per ogni angolo della città: Viva San Marco!». Il 18 aprile i rettori erano già partiti per Vicenza, intanto Emilei si apprestava a raggiungere Venezia per contattare il Senato, mentre a Verona Maffei e gli altri capi militari cercavano di organizzare l'esercito e il popolo.
La notizia della fuga dei due provveditori irritò la popolazione, che continuò ad agire senza coordinazione, mentre dalla provincia accorrevano numerosi i contadini e i montanari. Giuliari ordinò ai comandanti di fornire armi a chi ne fosse sprovvisto. Intanto alcuni cittadini riuscirono a portare dei pezzi di artiglieria sul colle San Leonardo. Nel frattempo da Bassano del Grappa giungeva il conte Augusto Verità che si mise a capo di 200 galeotti austriaci. I francesi furono obbligati a sgomberare da Castelvecchio mentre altri colpi mietevano vittime tra gli uomini sulle mura del castello. Poco prima di un nuovo assalto al castello un drappello di soldati francesi uscì con una bandiera bianca, in segno di resa. Il capitano Rubbi con pochi uomini si avvicinarono per trattare: fu allora che i francesi smascherarono un cannone e cominciarono a colpire, uccidendo i soldati che erano andati a parlamentare e 30 civili (vigliacchi). Si scatenò così l'inferno attorno al castello, mentre i tempi della rivolta venivano scanditi dalla campana della torre dei Lamberti, che i francesi cercarono inutilmente di abbattere con le artiglierie.
Dai paesi della provincia continuarono ad accorrere numerosi i civili volontari, armati per lo più di forconi, bastoni, e poche armi da fuoco: appariva sul volto di tutti il desiderio di morire per la Patria. I contadini della Vallagarina riuscirono ad assalire e conquistare Rivoli Veronese, mentre i montanari della Lessinia attaccarono da nord i forti San Felice e San Pietro. Il 19 aprile Bevilacqua venne sconfitto a Legnago dalle truppe francesi mentre Miniscalchi venne bloccato a Bardolino, per cui fuori dalle mura resisteva solo Maffei a Valeggio, che decise di ripiegare a Sommacampagna con 900 fanti e 250 cavalleggeri: arrivato a Sommacampagna lasciò il comando a Ferro e rientrò a Verona in cerca di ordini. Dopo l'inutile tentativo di mediazione, Contarini e Giovannelli organizzarono il popolo che, al grido di «vogliamo la guerra», si preparò a una difesa a oltranza della città.I francesi andavano ad appiccare incendi nei palazzi circostanti appartenenti a famiglie nobili dando così alle fiamme numerose opere d'arte. Tra cui il palazzo Liorsi e palazzo Perez, anche se tornarono solo 5 soldati, poiché gli altri furono uccisi dai Veneti.Presso il lazzaretto di Sanmicheli, passò una schiera di contadini armati diretti verso la città, quando dall'ospedale partirono alcuni colpi di fucile: i contadini, infuriati, abbatterono le porte e massacrarono i sei soldati che si trovavano all'interno.
20 e 21 aprile
Maffei la mattina seguente uscì con gli uomini disponibili da porta San Zeno per cercare di rompere la linea nemica e aiutare la ritirata in città delle truppe venete comandate da Ferro, ancora tagliate fuori. L'attacco di Maffei venne però respinto, mentre nel frattempo Ferro, che tra le sue truppe aveva 500 fanti del quarto reggimento di Treviso, 400 schiavoni, (civili volontari) 250 cavalleggeri e otto cannoni, poté rafforzarsi con oltre 4.000 volontari (i quali si erano spontaneamente riuniti a Sommacampagna dopo l'accerchiamento). Alla fine della battaglia tra fanti e schiavoni erano sopravvissuti in 400, mentre i cavalleggeri non subirono grandi perdite. Ripresero allora le trattative tra veneti e francesi, che richiedevano la resa senza condizioni, mentre nel frattempo altri volontari giungevano dalla bassa Veronese e, oltre a Verona, anche Pescantina respingeva gli assalti francesi, che non riuscivano così a oltrepassare l'Adige. Il 21 aprile continuava l'assedio a Castelvecchio, ormai però non c'erano più speranze di vittoria, nonostante fossero giunte da Vicenza al comando del conte Erizzo 400 fanti e circa 1.000 cernide, poiché l'abitato era ormai circondato da 15.000 soldati francesi.
22 e 23 aprile
francesi la mattina del 22 aprile portarono alcuni cannoni presso porta San Zeno con l'intenzione di abbatterla, ma furono fermati grazie a dei fortunati colpi di cannone sparati dalle mura da alcuni cittadini, che li obbligarono nuovamente, a ritirarsi; i militari ancora all'interno di Castelvecchio erano in grave difficoltà.Oramai era chiaro che i veronesi, nonostante fossero riusciti a contrastare le incursioni di pattuglie francesi e a sopportare il cannoneggiamento della città, non avrebbe potuto resistere da soli all'assedio di 15.000 soldati, per cui il 23 aprile si prese la decisione della resa e si inviò un messaggio a Balland in cui si richiedeva un armistizio di 24 ore. Alla fine degli scontri,quasi 4.000 soldati francesi dei circa 18.000 (tra morti, feriti e prigionieri) furono messi fuori combattimento.Il 24 aprile, verso mezzogiorno, il capitano Emilei e altri ambasciatori si incontrarono con Jacques-François Chevalier per trattare la resa: i francesi esigevano che la cavalleria veneta scortasse l'entrata delle truppe francesi in città (ma appiedata e disarmata), la restituzione dei prigionieri e delle artiglierie, il disarmo della popolazione, la consegna di 16 ostaggi, tra cui Emilei, Maffei, Verità, i provveditori, il podestà, il vescovo e Miniscalchi.
Alle 8 di mattina del 25 aprile 1797 (giorno della festa di San Marco) la città si arrese. Finì la strenua resistenza del Popolo Veneto contro gli invasori Giacobini e francesi a Verona.Nonostante i francesi avessero già confiscato il denaro della cassa pubblica, le città occupate dovevano pagare un tributo di 20.000 zecchini, ovvero 1.800.000 lire torinesi (che poi aumentarono a 2.000.000 lire). Il consiglio giacobino, varò un prestito forzoso di 2.400.000 lire e obbligò la consegna dell'argenteria delle chiese e di altri luoghi di culto.Il 4 maggio venne inoltre richiesto alle sessanta famiglie più facoltose un esborso compreso tra i 3.000 e i 15.000 ducati.Furono poi arrestati Emilei, Garavetta, Maffei, il vescovo Giovanni Andrea Avogadro, Giovanni e Francesco Giona, Contarini e la moglie, Leonardo Foscarini, il conte Rocco San Fermo, i dottori Vincenzo Aureggio e Francesco Pandini, Giacomo Augusto Verità, ma anche molti popolani. A questi si aggiunsero successivamente il conte Nogarola, il canonico Morasini, i tre fratelli Miniscalchi, e altri popolani (almeno 100). Il processo dei 7 principali imputati ebbe inizio il 15 maggio e vide la condanna a morte del conte Francesco Emilei per aver provocato la rivolta, del conte Augusto Verità, di Giovan Battista Malenza, e del vecchio frate cappuccino Luigi Maria da Verona.«Io non voglio più Inquisizione, non voglio Senato, sarò un Attila per lo stato Veneto.» Le condanne a morte in città furono quasi tutte di civili (alcune fonti 50, altre addirittura 200)E i francesi bruciarono quasi 30 acri di terreno coltivato dei contadini, sequestrarono armi (usate in futuro per invadere altri paesi e uccidere altri civili).Il 28 aprile, al rientro degli ambasciatori in città, i Savi disposero di non convocare più il Senato, mentre Vicenza e Padova venivano occupate dai francesi (sacche di resistenza, di alcuni patrioti, contadini e soldati, non mancarono, ma si ricevette l'ordine dal senato di non attaccare e di rimanere neutrali). Nell'ennesimo tentativo di placare Napoleone il 4 maggio, con 704 voti favorevoli, 12 contrari e 26 astenuti, il Maggior Consiglio revocò l'ordine generale di reclutamento per le cernide della Dalmazia. L'8 maggio il Doge si dichiarò pronto a deporre le insegne nelle mani dei capi giacobini, invitando nel contempo tutte le magistrature allo stesso passo. Nel frattempo cercarono di far ritirare il Doge a Zara. Venezia d'altra parte disponeva ancora della propria potente flotta e dei possedimenti istriani e dalmati, oltre che delle intatte difese della città e della laguna.
Nel corpo della nobiltà serpeggiava però il terrore di una possibile rivolta popolare. L'ordine diramato fu quindi quello di smobilitare le fedeli truppe di Schiavoni presenti in città.La sera dell'11 maggio, con l'ultima riunione del Maggior Consiglio l'anziano doge esclamò:«Stanote no semo seguri gnanca nel nostro leto.»(Stanotte non siamo sicuri neanche nel nostro letto.)La mattina del 12 maggio, il Maggior Consiglio della repubblica si riunì per l'ultima volta e nonostante alla seduta fossero presenti solo 537 dei mille e duecento patrizi aventi diritto e mancasse quindi il numero legale, il doge, Ludovico Manin, aprì la seduta, ufficializzando la fine della Repubblica Serenissima e la resa ai Francesi. Terminò così la Repubblica Serenissima, che durò 1.100 anni.

.jpeg)
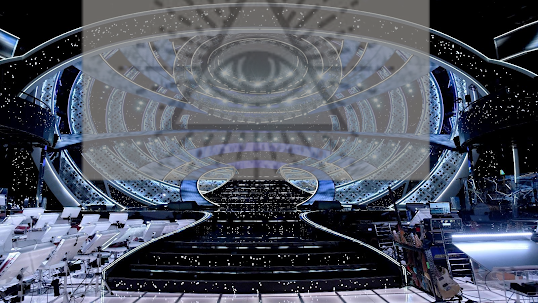

Commenti
Posta un commento