TORINO ESOTERICA: IL CINEMA STATUTO, LA GRAN MADRE ED ALTRI MISTERI
Ribelle Non Conforme ha bisogno del tuo supporto;
Misteri
La città di Torino è nota nel mondo per essere il vertice della magia bianca con Praga e Lione e della magia nera con Londra e San Francisco. Come mai il capoluogo sabaudo è stato spesso considerato come una città "satanica"? Probabilmente a causa dei fatti avvenuti nel Risorgimento. In quell’epoca il governo piemontese lasciò libertà di culto ai gruppi religiosi e "magici" alternativi alla Chiesa, al fine di ostacolare il potere del Papa. Queste voci, però, arrivarono fino ai tempi moderni, culminando con una serie di fatti di cronaca alquanto inquietanti avvenuti all’inizio degli anni Ottanta. Tra il 1981 e il 1983 uno studio condotto dall’Università di Torino scoprì che in città ci furono ben 1350 casi di possessione demoniaca. Nella maggior parte si scoprì che si trattava di disturbi psichiatrici, paranoie, crisi nervose e malattie. Di questi infatti, solo 16 casi furono ritenuti "possibili".
La Massoneria aprì una loggia a Torino solo nel 1859: la loggia Ausonia. Ciò nonostante molti dei federati e dei carbonari, promotori tra l'altro dei moti del 1821, provenivano dai suoi ranghi. La Massoneria, le cui origini risalgono alla fine del XVI secolo come corporazione di scalpellini e muratori, fissò nel 1717, con la fondazione della Gran Loggia di Londra, i simboli, le forme e i riti in uso ancora oggi.
L’8 ottobre 1859, infatti, in pieno Risorgimento, sette uomini si riunirono in via Stampatori, a Torino, per fondare quella che al tempo era una vera novità: le organizzazioni di questo genere presenti al Nord erano tutte di matrice francese, frutto dell’influenza culturale seguita all’avvento di Napoleone, mentre al Sud, ancora terra borbonica, le presenze si rifacevano alle radici spagnole o inglesi. E così in un’Italia non ancora Paese unitario sorgeva la loggia massonica torinese che porta il nome antico della nostra Penisola, giunta oggi all’importante traguardo dei suoi 160 anni di esistenza - oggi nelle mani del Grande Oriente d'Italia.
Nel contesto di Logge sorte nei diversi Stati italiani nel periodo del Risorgimento, Ausonia fu la prima a perseguire l’obiettivo di costituire un organismo massonico nazionale nell’Italia unita sotto i Savoia: questo processo creativo fu appoggiato da Camillo Benso conte di Cavour.
Il "capodanno del Diavolo" del 1983
L’apice di questi fenomeni esoterici e satanici arrivò nel febbraio del 1983. In quell’anno il Comune pensò di organizzare un evento a tema chiamato "il carnevale diabolico". Il giorno seguente, il 13 febbraio, si verificò un incendio nel cinema Statuto che provocò un numero di vittime curiosamente simmetrico: 31 uomini, 31 donne, 1 bambino e 1 bambina per un totale di 64, il numero delle caselle della scacchiera del Diavolo. Gli appassionati di esoterismo notarono altre due coincidenze: il giorno della tragedia portava il numero 13, che corrisponde alla carta della Morte sui Tarocchi. In più, il film in programmazione si intitolava "La capra", considerata da sempre il simbolo del Diavolo.
Statua di Lucifero a Piazza Statuto
Dopo la tragedia del febbraio 1983 molti residenti di Torino cominciarono ad andare in psicosi dopo che il 26 giugno 1984 il cardinal Anastasio Ballestrero denunciò apertamente i furti sacrileghi di ostie consacrate ed il proliferare di rituali per adorare il Diavolo all’interno della città. "A Torino le sacre specie si profanano. I riti satanici della profanazione dell’Eucarestia si ripetono - è orrendo a dirsi - c’è chi fa delle specie eucaristiche profanate a testimonianza resa a degli scellerati di aver tradito Cristo e di essersi consegnato a Satana", affermò all’epoca il cardinal Ballestrero. Il fatto venne commentato anche dal teologo domenicano Giacomo Grasso. "Stupito? No, affatto. Che ci siano messe nere e riti satanici è un fatto. E che ci siano, e In crescita, furti di ostie consacrate è una realtà" affermò. "Non di ieri, ma di anni. C’è chi dice che a Torino e nelle altre città italiane esistano migliaia di gruppuscoli che si dedicano a questo tipo di riti. Torino capitale dell’esoterismo? È probabile. Ma è sicuro che in città gli «attentati alle ostie» abbondano", commentò il giornalista.
Poco tempo dopo, però, il cardinale autorizzò ben sei nuovi sacerdoti esorcisti solo per la città di Torino. Questo creò ulteriore preoccupazione perché all’epoca in tutta l’Italia si poteva trovare un solo prete esorcista per ogni regione. Il vicario generale dell’arcivescovo, monsignor Franco Peradotto, spiegò il motivo del numero insolito di esorcisti: prima di tutto dovevano sostituire i sacerdoti precedenti, ormai troppo anziani. Inoltre, si scelse un numero così alto proprio per fare chiarezza sul fenomeno in aumento e soddisfare le richieste dei fedeli. La verità di quegli anni fu una semplice esaltazione di bizzarri fenomeni, con un’eco mediatica troppo marcata che provocò dei racconti "esagerati" degli eventi.
I luoghi dell'esoterismo a Torino
Come già detto in precedenza Torino rappresenta il vertice di due triangoli magici: il primo, quello bianco, con Lione e Praga, mentre il secondo, quello nero, assieme a Londra e San Francisco.
Secondo gli esoteristi, piazza Castello è ritenuto il luogo più positivo della città - nel punto di congiunzione tra i due Dioscuri Castore e Polluce di Palazzo Reale - mentre piazza Statuto è tristemente deputata al male ed alla confluenza di energie nefaste.
Piazza Castello
In Piazza Statuto, ai tempi degli antichi romani, finiva la città – o meglio dire quello che allora era l’accampamento – e iniziava la strada che portava verso la Gallia, l’attuale Francia. Dove si trova ora Porta Susa c’era la Porta Segusina. Per questo il lungo corso che parte da questa piazza si chiama corso Francia. Nel mondo degli antichi, dove si dava molto significato alle congetture naturali, questa parte della città si trovava ad occidente, dove muore il sole e iniziano le tenebre, quindi considerata una zona infausta, il confine tra il modo del Bene e quello del male. Fuori dalla Porta Segusina venivano guistiziati i condannati e tumulati i defunti. Qui iniziava la grande necropoli che andava da corso Francia fino a Via Cibrario e corso principe Eugenio. Furono i francesi a spostare il patibolo a "L rondò dla forcà dove venivano giustiziati con la ghighiottina - la "beatissima" - i criminali, uno slargo all’incrocio tra gli attuali corso Regina Margherita, corso Valdocco e via Cigna: prima si trovava in questa piazza, che è considerata il centro della magia nera della città. Nel 1864 teatro di sanguinosi scontri in occasione dei tumulti per il trasferimento della capitale. La stessa etimologia di Valdocco sembra derivare da Vallis Occisorum - Valle degli Uccisi - per essere un altro luogo deputato alle esecuzioni capitali ai tempi dei romani. Infine alcune fonti affermano che in prossimità di corso Valdocco sia stata sterminata tutta la legione tebana in un aspro combattimento. Alcuni dicono che non sia un caso che proprio lì sorga la Basilica di Maria Ausiliatrice dove riposano le spoglie di San Giovanni Bosco che sembra quasi porre un rimedio “energetico” alla presenza di tante anime sofferenti. Gli esoteristi però ravvisano come esatto luogo di massima negatività della città, il monumento che si trova al centro di piazza Statuto. Qui, nel 1879, fu eretto il Monumento al Traforo del Frejus - opera del conte Marcello Panissera di Veglio - inaugurato alla presenza di Umberto I. Con una struttura a piramide costituita da massi trasportati appositamente dal monte Frejus, è sormontata da un Genio alato sotto il quale si trovano figure marmoree dei Titani. È un’allegoria del trionfo della Ragione sulla forza bruta anche se un’altra interpretazione la identifica come memoria ai caduti periti durante i lavori di scavo. Raffigura degli uomini che sembrano voler salire sulla cima del monumento, quasi a raggiungere l’angelo in cima, che ha in mano una piuma o penna d’oca che rappresenta il sapere, mentre l’altra mano non ha proprio un atteggiamento benevolo nei confronti delle statue raffiguranti uomini che si stanno spingendo verso di lui, come li volesse fremare per impedirgli di raggiungerlo, per impedirgli di sapere. Sulla cima del capo dell’angelo spicca una stella a cinque punte che a livello simbolico rappresenta il microcosmo ed il macrocosmo con i cinque vertici a rappresentare gli altrettanti elementi metafisici dell’acqua, del fuoco, della terra, dell’aria e dello spirito. Usato come sacro amuleto pagano, è doveroso ricordare che simboleggia anche l’anticristo. Ad osservare attentamente ogni suo tratto, egli è talmente avvincente da proporre una natura malevola. In alcuni testi si legge che l’essere alato in questione sarebbe la rappresentazione di Lucifero, "Portatore di luce" - in ebraico הילל o helel, in greco φωσφόρος; in latino lucifer "stella del mattino”, o anche Vespero "stella della sera" - l’angelo più bello secondo la tradizione biblica cristiana.
Non a caso la CGIL e i gruppi di sinistra come Autonomia Operaia hanno sempre utilizzato piazza Statuto, soprattutto negli anni '60 e '70, come principale punto di ritrovo. Il significato esoterico c'è.
Inoltre vi è La Porta per l’Inferno. al centro della piazza presso la fontana del Frejus, da sotto l’aiuola centrale, vi è l’accesso che conduce al sistema fognario che qui ha il suo snodo principale. Anche questo elemento favorì il crearsi di leggende e credenze che vogliono la Piazza come fulcro della magia negativa o, addirittura, punto di ingresso di una delle tre Grotte Alchemiche che sarebbero presenti in città.
E poi ancora, l’obelisco e l’astrolabio, vertice del triangolo oscuro, e il Tombino per l’Inferno, vertice del triangolo della magia nera - gli altri sarebbero Londra e San Francisco - difatti si ritiene che il vertice di tale triangolo cada nel punto indicato da un piccolo obelisco con un astrolabio sulla sommità, situato nell’aiuola del piccolo giardinetto di fronte al monumento del Traforo ferroviario del Frejus. Questo obelisco fu eretto nel 1808 su un punto preciso, in ricordo di un vecchio calcolo trigonometrico del 1760 sulla lunghezza di una porzione di meridiano terrestre - il Gradus Taurinensis - eseguito insieme ad altri punti geografici nei comuni piemontesi di Rivoli - nel quale c’è un obelisco gemello - di Andrate e di Mondovì, ad opera del celebre geofisico matematico piemontese Giovanni Battista Beccaria. A quest’ultimo fu anche intitolato il piccolo tratto di corso che parte dal giardinetto dell’obelisco verso il corso Principe Eugenio. Vicino alla sua base c’è un tombino che si dice permetta di accedere direttamente alle porte dell’inferno.
La Gran Madre
La Gran Madre di Dio, insieme al Duomo, è la chiesa più celebre di Torino. Questa è ricca di significati e simbologia esoterica.
Classificato come luogo di culto cristiano per alcuni, catalizzatore di energie esoteriche e misteriose per altri.
La Gran Madre di Torino è oggetto di curiosità sia per la sua denominazione, che per la scelta del luogo dove sorge.
Secondo alcuni, infatti, il concetto di "Madre di Dio" non è prerogativa cristiana, ma è comune anche al culto pagano della dea Iside.
Inoltre, sembra che nel luogo oggi occupato dalla Gran Madre una volta sorgesse un tempio dedicato proprio al culto della dea.
La storia
Dopo anni di esilio dovuto al dominio napoleonico, nel 1814 i Savoia fanno finalmente ritorno nei propri possedimenti. Lacittadinanza decide quindi di celebrare l’evento con la costruzione di un imponente monumento, ovvero la chiesa della Gran Madre.
L'intenzione era quella di conferire continuità al profilo cittadino e dare una conclusione alla prospettiva che unisce piazza Castello alla collina. Per dare forma al progetto viene chiamato Ferdinando Bonsignore, che inizierà i lavori nel 1818 e li concluderà solo nel 1831, con l’inaugurazione alla presenza di Carlo Alberto.
Per sottolineare la dedica ai Savoia, Bonsignore inserì un’incisione sulla trabeazione della facciata della Gran Madre che recita: “Orde Populusque Taurinus ob Adventum Regis”.
Cioè: la nobiltà e il popolo di Torino per la venuta del Re.
Una frase in lingua latina, con cui i torinesi salutano il ritorno di Vittorio Emanuele I di Savoia, che il 20 Maggio del 1814 riprendeva il controllo dei possedimenti piemontesi. Anche i bassorilievi del timpano oscillano tra personaggi religiosi e politici, come a ricordare il legame con il ritorno della casa regnante a Torino. Salendo verso la sommità della Gran Madre di Dio è impossibile non notare il bassorilievo del frontone che rappresenta una Madonna col bambino omaggiata dai committenti cittadini.
Nonostante la ricchezza e la cura dei particolari, ciò che salta subito all’occhio è la forma della chiesa, fortemente voluta da Ferdinando Bonsignore, che richiama quella del Pantheon di Roma seppur con un’inflessione più neoclassica.
Non c’è dubbio, dunque, che a prima vista passi proprio come antico tempio romano dedicato a tutti gli dei.
Prima di accedere al sagrato della Gran Madre, infatti, bisogna percorrere un’imponente scalinata protetta, per così dire, da due statue poste ai lati.
Le due sculture rappresentano la Fede e la Religione e, nei secoli, hanno contribuito a creare il manto di mistero che circonda la chiesa della Gran Madre.
La statua della Religione ha le fattezze di una donna, vestita con un lungo abito, chiuso sotto il seno da un nastro e coperta da un manto che scende fino a terra. Al suo fianco è posto un giovinetto che le porge delle Tavole di pietra, sulle quali la statua punta un dito, anche se non presentano alcuna iscrizione. La mano destra della Religione invece regge una croce latina che la supera in altezza, ma la donna non sembra provare fatica. La croce in questione è anche l’unica presente in tutta la chiesa. Questo dettaglio potrebbe indicare la natura esoterica di questa chiesa che, pur essendo un luogo di culto cristiano, non presenta all’interno o all’esterno alcuna croce.
Altra particolarità della Religione è l’incisione presente sulla fronte scoperta.
È un triangolo con un occhio al centro, che secondo la simbologia cristiana rappresenta lo sguardo onnisciente di Dio che si dirama in ogni direzione. Qui lo scultore ha voluto giocare con l’ambiguità, poiché lo stesso simbolo appartiene anche alla tradizione massonica. Infine ai piedi della statua è posta una tiara papale, forse a simboleggiare la caduta del potere della Chiesa e all’avvento di altre e misteriose forze.
Il secondo gruppo statuario che veglia sull’ingresso della Gran Madre a Torino rappresenta la Fede. Anche in questo caso lo scultore ha deciso di rappresentare una donna, abbigliata quasi come la Religione, ma con dei dettagli differenti. Infatti qui il nastro della veste è intrecciato e forma un X sul petto, ma non sono presenti simboli sulla fronte. In questo caso la mano destra regge un libro aperto, come a far intuire una verità rivelata. La sinistra invece tiene un calice e, anche in questo caso, la statua guarda in direzione della città. Proprio questa coppa è stata oggetto di misteri poiché, secondo alcune interpretazioni, rappresenterebbe il Graal e lo sguardo della statua indicherebbe il punto della città dove è nascosto. Però la scultura della Fede non ha pupille, il che rende impossibile individuare un punto preciso. Che la Grande Madre abbia custodito, in un tempo lontano, il Sacro Graal o custodisce qualche segreto di questo?
Fonti


%20(6).jpeg)

.jpg)





.jpg)
.jpg)







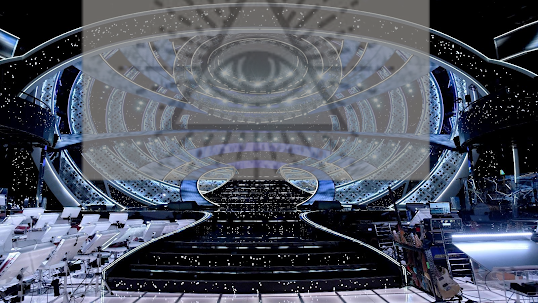
Commenti
Posta un commento